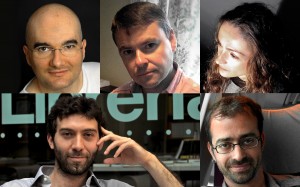Anche quest’anno il settembre meneghino ci ha offerto “TRAMEDAUTORE. Festival Internazionale del Teatro d’Autore”. Giunto alla sua XV edizione, dall’11 al 20 scorsi ha acceso le serate del Piccolo Teatro di Milano con spettacoli, incontri e proiezioni sul tema: “La Cina e le sue grandi Trasformazioni”. Già, perché se anche la Cina è una presenza quotidiana e tangibile, oramai, nella nostra città, poi però si rischia di cedere alla semplificazione “Cina=Chinatown”, che, da zona Paolo Sarpi, si è lentamente e oramai capillarmente propagata in tutta la periferia milanese con picchi di concentrazione commerciale nei vialoni che portano fuori dalla metropoli.
Eppure il progetto di Angela Calicchio – codirettrice artistica della rassegna, insieme a Tatiana Olear – parte da molto più lontano e punta molto più in là: non uno spaccato della Cina vicina delle fiorenti attività commerciali cheap and speedy, ma la voglia e il coraggio di un confronto diretto col colosso economico e culturale cinese per come è nella sua sconfinata patria e per come si rapporta con l’Occidente e la nostra cultura.
E’ da un po’ – correva l’anno 2006… – che la Calicchio voleva portare in scena la Cina di Oggi: quella che ha animato la Rivoluzione Culturale del “68 sì, ma poi ne è rimasta “sotto” – con le sue campagne di “rieducazione”, tramite cui spurgare gli intellettuali non allineati di allora. Un progetto ambizioso e coraggioso, sì diceva, finalmente coronato in quest’edizione con la messa in scena di testi realmente capaci di tinteggiare gli umori e gli spaccati della cultura cinese ai nostri giorni. Otto gli spettacoli proposti: tutti testi originali, in due casi recitati e diretti da artisti cinesi – come “Cent’anni di architettura cinese” di Mathias Woo, in mandarino, e “Parti prima di diventare vecchio” di Shao Zehui, in cantonese –, negli altri mises en éspace, che hanno offerto a sei giovani registi italiani l’occasione di cimentarsi con una drammaturgia non così consueta; ed è stato interessante assistere all’approccio.
Intanto titoli e argomenti. “Fake single” di Ha Zhichao, dramaturg Greta Cappelletti (con Valentina Mandruzzato, Marcello Mocchi, Marco Rizzo ed Emilia Scarpati Fanetti) racconta, coi toni leggeri della commedia e i colori vivaci di una città che solo accidentalmente è Pechino, di una società yuppie e a tal punto incentrata su produttività e carrierismo da negare ai dipendenti di una multinazionale dall’assetto smaccatamente occidentale perfino la possibilità di avere una vita privata, nel timore che questo possa distrarli dalla più assoluta dedizione al lavoro. Sono giocate le corde della commedia – meglio, sit-com – con tanto di gag, applausi registrati fuori scena, personaggi quasi caricaturali e tutti i colori del pop – fin dallo stacchetto “Single Ladies” di Beyonce o l’incipit simil rap, che ironizza sulla meta teatralità delle relazioni di ogni giorno. Ciò non impedisce di sfiorare alcuni temi un po’ più profondi: la paura d’amare, la complicatezza delle relazioni umane, specie uomo-donna, e la fragilità di una generazione che proietta nella virtualità di un video gioco o di relazioni performanti, gerarchizzate, ostentate, sottomesse, ma mai autentiche, l’incapacità di evolvere oltre un cliché. Finale happy end – da modello americano -, che butta il tutto in happy friendly. Queste, la scelta di una regia, che usa lo spazio vuoto riempiendolo di azioni sceniche vivaci, grazie anche alle capacità istrioniche dei giovani attori.

“Contratto matrimoniale” di Pan Jun regia di Sergio Basso (con Giusy Emanuela Iannone, Silvia Giulia Mendola, Ivan Olivieri, Valeria Perdonò e Michele Radice). Mutatis mutandis, la tematica è ancora quella: la difficoltà nelle relazioni sentimentali, al punto che il protagonista, reduce da un divorzio, arriva a proporre alla nuova compagna un contratto matrimoniale “rinnovabile” di anno in anno. Non sembra essere la mancanza di lavoro o quelle condizioni di precarietà economica, che affliggono molti di noi qui in Italia ciò che perturba i drammaturghi cinesi – giovani, come nel caso di Ha Zhichao, classe 1987, autore di “Fake single” o meno giovani, come l’autore di “Contratto matrimoniale”, nato esattamente 30 anni prima e che sente su di sé meno le vibrazioni generazionali del rampantismo e di più, probabilmente, quelle della difficoltà di gestire un fallimento matrimoniale. Quel che invece sembrano dire è di un mondo globalizzato, in cui quel che succedere a Pechino, Hong Kong o Shangai potrebbe tranquillamente essere successo a New York, Roma o Parigi: le stesse difficoltà di non sentirsi mai davvero parte di una comunità, ma di doverselo accaparrare con negoziazioni e contratti più o meno legalizzati o ortodossi, quel riconoscimento relazionale, che una società individualista e deflagrata in schegge solipsistiche non sa più garantirci. E allora da cosa capiamo di essere in Cina? In questa messa in scena, il regista cerca di restituircelo fondamentalmente con una scelta vocale ben precisa: li fa quasi cinguettare, gli attori – e le attrici, soprattutto –, riproducendo nella musicalità della loro modulazione quei falsetti e quelle risatine, che ci dicono subito Cina.
E poi “Il cinghiale”, “La fuga”, “Cinglish” e “Carbone attivo”. Il primo dei quattro, di Candance Chong Mui-ngam, regia di Maria Cristina Madau (con Sara Bellodi, Giovanni Calò, Veronica Franzosi, Marco Rizzo e Giuseppe Palasciano) è un testo forte, sulla carta, che tratta ancora una volta di censura, edilizia e intrighi politici – tematiche affini a “Cent’anni di solitudine”, con cui condivide il binomio edilizia e potere, quasi a dimostrazione che tutto il mondo è Paese e quello è un busìness, in cui spesso si addensano interessi economici trasversali. Ancora una volta una lettura scenica, copione alla mano, su un palco spoglio, in cui troneggia un tavolo. Attorno a questo gli attori in parte recitano e in parte costruiscono il loro interminabile castello di carte da gioco. La metafora dovrebbe giungere forte e chiara, ma la regia sembra un po’ troppo macchinosa e perfino i momenti più poetici – il racconto che la cameriera fa a proposito di suo figlio, ad esempio – o quelli di maggior cinismo – i voltafaccia: a chi si può davvero credere? – rischiano di restare sfuocati dal tentativo di dare una coerenza formale al tutto. Non meno criptico “La fuga” del Premio Nobel Gao Xingjian (con Carlotta Piraino, Mirko Soldano e Diego Valentino Venditti). Qui la regia è affidata a Lorenzo Montanini, che, con un sottile gioco di danza e con l’uso ad oltranza di un buio che ben restituisce il pathos e la claustrofobia del magazzino abbandonato, ma anche il freddo e la cecità delle relazioni interpersonali, muove continuamente i personaggi-pedine di quel gioco al massacro, che si sta giocando fuori. Siamo a Pechino, all’epoca dei fatti di Piazza Tienanmen, ma quel che al drammaturgo pare stia a cuore è non tanto dare una lettura sociale o politica di quegli eventi, quanto interrogarsi su quel triangolo relazionale – una giovane donna e due uomini: un coetaneo di lei e un giornalista ben più maturo E’ la dinamica fra i tre fuggiaschi a simboleggiare la cellula di violenza, odio, prevaricazione, manipolazione e dominio, che divampa, in modo più totalizzante ed esplosivo, fra i quartieri della città o, al contrario, le loro dinamiche relazionali distorte sono invece l’epifenomeno del virus, che ha contagiato chi di quegli scontri è vittima?

E poi gli ultimi due appuntamenti: “Cinglish” di David Henry Hwang, regia di Omar Nedjari con la supervisione artistica di Serena Sinigaglia (in scena Valentina Cardinali, Angelo Colombo, Enrico Maggi, Annagaia Marchioro e Federico Zanandrea), e “Carbone attivo” di Nick Rongjun Yu (con Sara Dho, Alessandro Lussiana, Gianni Quillico, Elisabetta Torlasco) per la regia di Manuel Renga, presente anche all’edizione passata del festival con “La mia massa muscolare magra”. Probabilmente le due restituzioni più azzeccate, giocate su note diametralmente opposte. Se Omar Nedjari, infatti, ha fra le mani un testo brillante, di cui riesce a mantenerne intatta la vena graffiante e sarcastica – passando attraverso a una comicità contagiosa, fatta dei cortocircuiti provenienti dal gioco linguistico e dalle semplificazioni intelligenti dell’ostentata traduzione/traslazione concettuale -, Manuel Renga se la gioca su note più poetiche e a tratti quasi riflessive, emotive e intimistiche, pur senza rinunciare a una corretta alternanza di generi, che dà ritmo e vivacità alla scena. Differenti, le trame: un sottile ordito d’interessi economici, commerciali e politici, in “Cinglish”, in una società dichiaratamente priva di un sistema giudizio – ergo: di un garante istituzionale – e tutta l’arte della negoziazione e del compromesso formale che molto immaginario attribuisce alla cultura cinese; in “Carbone attivo”, invece, il peso della famiglia e della tradizione – a partire dai piccoli gesti come il “cucinare per” – e la sua capacità di riassestare la giovane coppia in crisi, forse persa dietro alla sirena di un modus vivendi troppo occidentalizzato e spersonalizzante. E se anche il passato ha le sue macchie, il messaggio finale, però, converge sul non rinunciare alla propria identità tradizionale.
Ecco, questo, in fondo, il messaggio che sembra affiorare da questa rassegna – pur con tutta la parzialità del caso. Una Cina rampante, occidentalizzata, che se da una parte sembra pronta a gettarsi nel mondo occidentale – nelle sue dinamiche economiche, performative, politiche e globalizzanti -, per altro verso lascia trasparire tutta la differenza di chi si precipita verso un cambiamento, che forse lo snatura, rendendolo alla fine poi davvero adatto e vincente? Interessante la posizione delle donne, quasi fossero loro, principalmente, le reali protagoniste di questo cambiamento sociale: sembrerebbero le più adatte a sostenere il nuovo ruolo nel business, ma poi forse si rivelano elemento reale di caduta, in questo momento di transizione, che le vede puntelli irrinunciabili senza i quali si perde l’identità non più confermata dell’uomo cinese. Un processo culturale, che l’Occidente ha intrapreso – e… superato? -, già da qualche decennio e che sembra riportarci alle origini antropologiche del rapporto uomo-donna.
E, a tutto ciò, come si approcciano i giovani registi italiani? Con la chiave dell’ironia, per lo più, della leggerezza – come del resto fanno specie i più giovani dei drammaturghi (sino)americani, quanto meno nella mentalità – e di una costruzione scenica che, complici anche i strettissimi tempi a disposizione, si gioca più sulla relazione dei personaggi sul palco, che sulla cornice scenografica. Ci si concede qualche oggetto di scena; al più o si usano le luci – raffinate, totalizzanti e dai colori corposi, come in “Cinglish” o a pioggia quasi ad accendere questo o quel personaggio, come in “Contratto matrimoniale”, fino al paradosso di intere scene recitate quasi al buio, come ne “La Fuga”, in cui a mala pene si potevano intuire i movimenti degli attori. E poi la carta, altro topos tipicamente cinese nell’immaginario comune: sono gli uccellini/origami sospesi sulla scena di “Contratto matrimoniale”, che simboleggiano la vanità dell’accordo istituzionale scritto – come in “Cinglish”, ma anche ne “Il Cinghiale”, da cui emerge una Cina che non sembra nutrire grande fiducia nelle istituzioni -, ma anche il richiamo alla poesia della tradizione, fino al castello di carte de “In Cinghiale” o quei copioni stropicciati, che spesso gli attori portano in scena, a ricordarci la fatica e la passione del fare teatro: a qualsiasi età, cultura e latitudine.
Piccolo Teatro di Milano
Dall’ 11 al 20 settembre 2015
TRAMEDAUTORE 2015
...blogger per voyeristica necessità!
- Sempre più Tournée da Bar(do)! Quando il teatro si fa intelligente e sostenibile… - 8 Giugno 2018
- La guerra dei Guinea Pigs agli atti di bullismo e trasgressione - 25 Maggio 2018
- Lo struggente Cantico di Latini Premio Ubu - 18 Maggio 2018